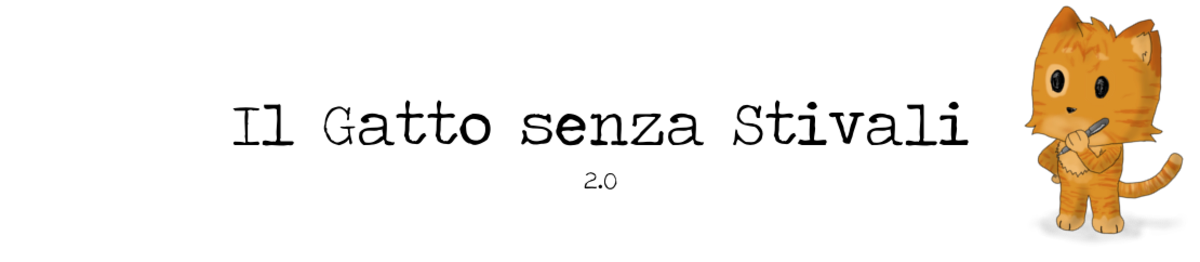Avere vent’anni non mi sta sembrando così bello.
Ecco, l’ho detto.
Voglio dire, tutto qui? Vedo le stesse facce di sempre, solo molto più impegnate a darsi un tono da uomo/donna impegnati. Aperitivi di qua, feste di là, pomeriggi in biblioteca, serate a ballare dove “c’è tutta Milano”.
Mi sembra che stiano tutti seguendo un grande copione. Un breviario con norme di comportamento e una non troppo vasta scelta di personaggi da interpretare.
Mi guardo intorno e vedo attitudini, non personalità, grandi discorsi e citazioni elaborate ma poca, poca sostanza.
C’è da dire che come osservatore partecipante non mi do troppo da fare. Come al liceo, o meglio, ciò che un tempo era il liceo, sono più le serate che passo a casa che non fuori a fare i bagordi. Sarà che ho iniziato presto ed esagerato, sarà che mi sono stufato della routine, sarà che non m’è mai piaciuto ballare, sarà che miro ottusamente a non fare quello che tutti fanno, sarà non so cos’altro, ma questi vent’anni tanto blasonati cominciano ad insospettirmi. Tutto qui?
Però ora che ci penso il problema non sta tanto nella giovane età, quanto nella gioventù da cui è formata. Non sarò certo il primo a dirlo, ma i giovani d’oggi non sono tanto giusti.
Non lo siamo, la maggior parte di noi è inetta. Davvero. Non è bello sentirselo dire, ma siamo dei buoni a nulla. Certo, ci sono le eccezioni, e ognuno di noi crede di esserlo. E mi sa che è questo il problema. Per cui farò finta che non ci siano eccezioni. Così nessuno è in diritto di chiamarsi fuori.
Tutti, nessuno escluso, che del resto è la definizione di tutti e quindi è pleonastico, siamo dei buoni a nulla.
Me ne stavo lì sulla panchina scribacchiare le mie sentenze senza il minimo senso di colpa. Il sole era già alto in cielo e dovevano essere le due, cominciavo ad avere fame. Ero uscito di corsa quella mattina, con un misero sorso di succo in pancia. La bici sembrava pesare un quintale mentre pedalavo e credevo di sciogliermi dal caldo, schivando passanti idioti e macchine ostinate a chiudermi a destra. Era domenica, non me n’ero accorto. Tutta colpa del doppio sabato. Ovvero del venerdì-come-sabato, ultima news dell’essere universitari.
Ero ovviamente convinto che fosse lunedì, perché dopo due serate fuori, il week-end, c’era il lunedì. Era sempre stato così, non c’era motivo per cui dovesse cambiare improvvisamente. I cancelli erano chiusi e c’era insolitamente poca gente in giro, e molti più vecchi con bambini ad orari improbabili.
Porca merda, era successo ancora. Stavolta in un modo ancora più irritante.
Vedete, io dormo in un modo strano. No, aspetta, non è proprio così, credo di dormire come chiunque altro. È che mi sveglio in un modo strano. Se sono riposato, bene, no problem, mi alzo e so dove sono, quando sono. Se mi sveglio strano, stanco, non distinguo troppo i ricordi dai sogni appena finiti, non ho i sensi ben attenti e tendo a fare confusione.
Di solito succedeva che, dopo aver dormito tutto il pomeriggio, soprattutto d’inverno, quando anche di mattina ci si sveglia che è buio, mi rivestivo e preparavo la cartella per andare a scuola, scendevo le scale e trovavo mia mamma che preparava la cena.
Era uno choc. Ed era tutta colpa del fatto che mi mettevo in pigiama per dormire anche di pomeriggio, e… che porca troia dormivo cinque ore! Non è normale dormire così tanto in pieno giorno. Il punto è che almeno in quei casi non uscivo di casa, e dissimulavo facendo qualche stupida domanda sul cibo a mia mamma, come se niente fosse, e tornavo su con la risposta che in 10 minuti sarebbe stato pronto. Nessuno sapeva nulla, nessuno si preoccupava ed eravamo tutti più felici.
Stavolta avevo superato me stesso, avevo fatto più di sei chilometri senza pormi domande, senza realizzare l’errore. Senza svegliarmi, in fondo.
Non so se esiste un termine medico per questo. Probabilmente idiozia. Ma non è una vera e propria condizione, scientificamente parlando.
L’orologio faceva le dieci e mezza, il cielo era blu e luminoso, e un generoso sole quasi estivo stava percorrendo la sua scalata quotidiana.
Era pieno aprile e non mi capacitavo di come potessi non avere ancora preso il ritmo universitario ed avere confuso domenica con lunedì. Era già il secondo cazzo di semestre ed era pure primavera, come si fa ad essere così rincoglioniti?
La giornata prometteva bene, ed ero troppo incazzato con me stesso per concedermi di tornare a casa; per cui mi diressi al parco, come solevo fare al liceo in primavera, saltando a discrezione l’interrogazione di fisica o salcazzo. Ai tempi me ne stavo lì sulla panchina ad inaugurare i libri di testo comprati a settembre, in folli maratone pre-terza prova, o semplicemente a scrivere canzonette sui taccuini da radical chic della moleskin. Cioè, non canzoni a proposito dei taccuini, solamente sopra, sia chiaro. Ho di meglio da dire, di solito. Mmh. Di solito.
Comunque stavo lì, ore e ore, a fissare i piccioni analizzando il loro comportamento, oppure passeggiando di fianco all’ex zoo. Mai avuto molte cose da fare. O meglio, mai fatto le molte cose che avrei potuto o dovuto fare.
Stavolta ero semplicemente parcheggiato su una panchina a scribacchiare quello che mi passava per la testa. In men che non si dica s’erano fatte le due, come aveva confermato l’orologio del cellulare. L’abitudine di girare con taccuini da radical chic non deve portarvi a credere che io sia un radical chic, non lo sono, giuro. Non sono nemmeno troppo sicuro di sapere con esattezza cosa si intenda per radical chic, l’ho sempre tradotto in benpensante, solo di sinistra. Comunque mi piaceva l’idea di avere un posto in cui annotare al volo i miei pensieri. Inoltre spesso diventava un passatempo, nei momenti buchi o nelle lunghe attese dovute alla mia eccessiva e cronica puntualità. Certa gente fuma, e muore. Io preferivo scribacchiare, e nel peggiore dei casi farmi picchiare per le malignità che annotavo.
Che poi, più che malignità erano generalizzazioni.
Ero un campione a generalizzare, no, anzi, sono un campione a generalizzare. È più facile che non darsi risposte per scarsità di prove. O per umiltà e modestia, spesso falsa umiltà e modestia.
Ecco, l’ho fatto ancora; ma odio quelle persone che dicono “non mi va di dare un giudizio” o “non sta a me”. Checcazzo siamo creature pensanti: pensiamo perdio!
Per cui mi davo risposte, ad ogni domanda che mi ponevo trovavo una risposta soddisfacente e spesso molto, molto critica. E cinica. Erano le mie parole preferite. Critica e cinismo, intendo. Un mio sorta di dogma personale, vista la scarsa affidabilità di quelli proposti dalle religioni. O più che altro dalla scarsa affidabilità delle religioni stesse. E dei loro sacerdoti. Illusi.
Argh. Devo smetterla. Ho già probabilmente perso tutti i lettori dai vent’anni in su, chi indignato dalle accuse: i più giovani, chi dalle eresie: i più anziani. Per non parlare di tutti i radical chic. Quindi mi scuso con chiunque sia rimasto, non volevo ferire i sentimenti di nessuno. Magari richiamate chi se ne è andato, attirateli con dei cioccolatini, dicendo che troveranno degli amici, come fanno i ciellini. Facciamo finta che questo sia un grande gruppo di studio, solo che ascoltate tutti me. Non perché abbia più diritto di parlare, ma semplicemente perché questo è la mia cazzo di storia e non la vostra.
Per cui fidatevi, sono l’uomo giusto per questo lavoro, anche perché quella che scrivo è la mia storia, con le mie opinioni, quindi chi meglio di me potrebbe farlo?
Domanda di tutt’altra rilevanza è: chi mai potrebbe leggerlo?
Mah.
Rilessi al volo ciò che avevo scritto, non male, pensai, ma non avevo voglia di continuare; più che altro avevo fame. Mi ero punito abbastanza rimanendo fuori, era ora di tornare a casa e cucinarsi qualcosa di fresco, buono e sano. Pizza surgelata con ogni probabilità. Meglio di niente. Ogni anno, dalle scuole medie, c’è sempre stato qualcosa in casa da cucinare al volo. Ogni tanto cambiava, e qualche piatto finiva nel dimenticatoio. Prima sono venuti i toast, poi i cordon bleu, i ravioli, i 4salti in padella e le piadine. La pizza surgelata è stata una sorta di costante. Rimontai sulla bici e pedalai fino a casa, non distante da una delle entrate dei giardini. Era domenica, ora lo sapevo, quindi probabilmente nessuno era ancora uscito, e ognuno aveva pranzato come e quando meglio credeva.
Non abbiamo mai avuto grande rispetto dei riti e delle tradizioni famigliari, non nel senso teorico quanto in quello pratico, per cui finivamo per essere più che altro coinquilini. L’unica eccezione era la cena, ma più che altro per coincidenza e convenienza, in quanto di solito c’eravamo tutti, mentre a colazione e pranzo ognuno era schiavo dei propri orari e abitudini, sviluppate nel corso degli anni. Sia io che mio fratello abbiamo imparato a cavarcela da soli in queste faccende il prima possibile, che è guarda caso coinciso coi primi anni senza donna di servizio/baby-sitter.
Aperto il cancello parcheggiai la bici in giardino, buttandola dove capitava, tanto c’era bel tempo, ed entrai in casa. Come previsto, nonostante l’ora, aveva mangiato solo nostra madre, e mio fratello oziava davanti alla televisione.
“Oh, io mangio” gli urlai, “Tu che fai?”
Gli ci volle la solita decina di secondi e un uhm molto, mooolto scazzato prima di rispondere.
“Va bene, adesso scendo.”
Aspetta sempre talmente a lungo che le sue risposte non sono mai grammaticalmente fedeli alle domande, come in questo caso. Nessuno gli aveva chiesto scendi anche tu?, anche se il senso era ovviamente quello, eppure durante il suo tergiversare aveva scremato la domanda e risposto a quella implicita al suo interno. Mi fa morire.
Le pizze ovviamente c’erano, per cui cominciai a far scaldare il fornetto elettrico e strappai coi denti il cellophane che le avvolgeva. Non avevamo un forno a gas, non lo avremmo mai usato, troppo grosso per tre. Accesi a mia volta la televisione e mi misi a fissare i cartoni animati. La puntata stava finendo e come se non bastasse l’avevo pure già vista, ciononostante non riuscivo a staccare gli occhi dallo schermo, regredendo ad una forma primordiale di essere vivente. Mio fratello probabilmente era qualche stadio più indietro, al piano di sopra, non tanto per l’altitudine quanto per l’esposizione prolungata. Doveva essere rimasto a fissarli inebetito per almeno un’ora. Incredibile come diveniamo vittime inconsapevoli del progresso.
Mi svegliai dal coma televisivo ai titoli di coda ed infornai le due pizze, tutte e due insieme, non avendo voglia di fare a metà con la prima e poi infornare la seconda e aspettare altri cinque minuti, i programmi da essere umano di serie b stavano per iniziare, e per niente al mondo volevo assistervi passivamente mentre “cucinavo”.
Sapete cosa intendo, quei programmi.
“Prontooo.”
“Arrivooo.”
Tipico esempio della solerzia nei giovani d’oggi. Non c’era scampo.
Non era riluttanza, eravamo semplicemente scazzati. Quasi sempre scazzati.
Questa la grande piaga della gioventù. Svogliati, insoddisfatti e annoiati. Le soluzioni erano ad un palmo dal nostro naso; bastava cambiare, metaforicamente, canale. Ma qualcuno aveva nascosto il telecomando. Troppo sbatti alzarsi e farlo manualmente. Per cui ogni anno sempre più giovani nullafacevano e nullatenevano, vivendo alle spalle dei benestanti genitori, troppo affezionati e abituati a coccolare il loro “bambino” per accorgersi che non era più così brillante ed innocente. L’elemento trainante della classe, come scrissero su una mia pagella delle elementari. Se solo avessero saputo!
Spensi violentemente il televisore, togliendogli la corrente, alla prima inquadratura dell’irritante presentatrice bionda del pomeriggio. Per non fare nomi.
Maria DeFilippi. Per farne.
“C’è del prosciutto?” chiese mio fratello.
“Che ne so, guarda.”
Non mosse un dito. Ormai era seduto; ciò significava che fino a che non avesse finito di mangiare, con ogni probabilità, non si sarebbe alzato. Era fatto così, a tavola non faceva mai nulla, eravamo sempre io e la mamma ad alzarci. Peccato, perché di prosciutto ce n’era.
“Ieri sera sono stato in un posto dietro Buenos Aires,” attaccò “Che metteva su musica figa, misto indie, elettronica.”
“Quello nuovo che hanno appena aperto?”
“No, no, c’è da un po’ di anni; l’Atomic,” rispose “E pensavo di esserci già stato con dei miei amici tempo fa. E invece no! Era un altro. Non capirò mai che posto fosse.”
Sarà, pensai.
I suoi aneddoti sono spesso inconcludenti, ed ero abituato a non farci troppo caso, per cui tirai fuori le pizze e le schiaffai sui taglieri di legno tondi che usavamo solo in queste occasioni.
“Ma le hai fatte insieme?”
“Sì, non c’avevo sbatti.”
“Così vengono gommose.”
“Eh lo so, va be’, non avevo voglia di aspettare.”
Probabilmente precisò meglio in che modo venissero gommose, ma non mi ricordo; e a dirla tutta non sono nemmeno qui per parlavi di mio fratello; cioè, se vi interessa venite a conoscerlo, non rompete le palle a me, cristo. Sono qui per raccontarvi quello che successe dopo. Credo che sia importante. Una di quelle cose che a ricordarla vi viene in mente un determinato periodo della vostra vita. Che so, le vacanze di natale da bambino, l’estate della terza media, la maturità. Quei periodi che rimpiangerete per tutta la vita, perché senza troppo rendervene conto stavate passando i momenti più belli di sempre.
Okay, allora prima riassumiamo; vediamo se avete colto i punti più importanti: era primavera, la stagione più figa di sempre; era il mio ventesimo anno di vita, e non ne ero così entusiasta; avevo una leggera tendenza alla misantropia e un complesso di superiorità ben radicato, costantemente alimentato e accudito; era il mio primo anno di università, e stava andando piuttosto bene; ci trovavamo a Milano, vero centro nevralgico italiano, pieno di figli di papà, benpensanti, radical chic, sognatori illusi, sognatori disillusi, gay, lesbiche, ricchi, ricchi annoiati, ricchi che dissimulano, poveri, straccioni, nobili di ‘sto cazzo, preti, bambini viziati, tredicenni puttane e ventenni suore, idioti, idioti antropomorfi col booster, universitari e universitari parcheggiati, secchioni, bocciati, gente col culo coperto e gente che la prende nel culo, centinaia di peccatori e decisamente nessun santo.
Si era creato un equilibrio tra forze talmente stabile, che eri sicuro che niente sarebbe mai successo. E non succedeva. Non succedeva mai niente. È per questo che la mia storia è così importante. Perché che succeda o meno qualcosa, noi ci siamo, noi viviamo e inevitabilmente moriamo. La storia se ne frega di noi.
Finito di mangiare filai in camera mia e accesi istintivamente il computer. Era un gesto automatico, inevitabile. La mia droga. Non ho mai fumato e ho sempre considerato dei perdenti quelli che lo facevano, ma tutte le mie convinzioni e critiche contro i dipendenti, siano essi tabagisti o cocainomani, dovevano fare i conti con la mia dipendenza. Il computer.
Senza alcun motivo plausibile passavo le mie giornate al pc, ascoltando e ordinando musica, guardando film e telefilm, registrando canzoni e giocando al gioco per cui ero in fissa al momento. Più spesso semplicemente cercando un gioco per cui andare in fissa, cercando film e telefilm da vedere, cercando musica e cercando programmi per ordinarla.
Ero come ipnotizzato, il tempo passava e io non facevo niente per fermarlo. La mia camera era una cella a cui avevo messo i fiori alle finestre, e non volevo più uscirne. Di tanto in tanto mi passava per l’anticamera del cervello, ma la pigrizia aveva il sopravvento. Quella e la convinzione che niente di nuovo mi aspettava fuori, che vedere gli stessi posti, le stesse facce non mi avrebbe cambiato la giornata; anzi, mi sarei rotto il cazzo.
La Grande Noia mi aveva intrappolato, e io non avevo fatto la minima resistenza. Ora mi cullava come se fossi il suo bambino, un bimbo obeso troppo grasso per muoversi. Un motore immobile, solo che io ero pura potenza, perché in atto non mettevo proprio un cazzo. E a dir la verità stavo ingrassando sul serio. La mia un tempo slanciata figura aveva guadagnato con gli anni di inerzia una fastidiosa pancetta etilica, dura a morire.
Quel giorno lo schermo mi infastidiva. Ero ancora preso male per la genialata del mattino, e sospettavo che il computer potesse esserne responsabile in parte. Che so, magari favoriva il distaccamento dalla realtà, e associato ad una psiche fin troppo inventiva conduceva a fenomeni di smarrimento e confusione temporale. Ad ogni modo fissavo in cagnesco lo schermo, dubbioso sul da farsi. Nel senso di: che cazzo faccio?
La Noia era tornata, colpiva come sempre nell’attimo in cui mi ricordavo che non avevo programmi e non avevo niente di importante da fare, oltre a studiare. Ma con lo studio assumevo un atteggiamento alla ‘noli me tangere’ e lo tenevo a distanza. Purtroppo contro la noia avevo poche armi. Per cui mi misi a riguardare puntate a muzzo di How I Met Your Mother e accesi msn.
Solo pochi coraggiosi lo usavano ancora. Da quando facebook era sbarcato nel nostro paese, ogni idiota faceva a gara a chi postava più video inutili in un giorno. Msn, ormai vecchio e stanco, aveva ceduto il testimone, e, grazie al cielo, si era svuotato di tutti i ragazzini speciali che credevano sia a babbo natale, sia al fatto che prima o poi sarebbe diventato azzurro e a pagamento; per cui, terrorizzati, inondavano la tua casella di posta con le catene più fastidiose del momento, convinti che sant’Antonio altrimenti gli avrebbe offeso il culetto con molto più di una catena.
Spero che soffochiate nel sonno.
Avrei dovuto studiare, perciò risolsi il problema come facevo di solito. Rimandai.
Il presente me decise che il futuro me si sarebbe messo d’impegno e avrebbe studiato un sacco l’indomani, magari con una sveglia mattiniera. Fatto questo, solitamente il presente me si sentiva rassicurato e si godeva il resto della giornata senza preoccupazioni.
Il problema era che il futuro me non ci stava dentro a farsi inculare così dal presente me, per cui, con gran charme, spegneva la sveglia mugugnando e scaricava la responsabilità sul futuro anteriore me, che, svegliandosi verso le due del pomeriggio, si trovava alle strette coi tempi e con un leggero senso di colpa dovuto ai passati me — una manica di stronzi opportunisti — ed era costretto a rimandare al giorno dopo. Il tutto si ripeteva ciclicamente e ininterrottamente da anni. La procrastinazione — sì, è una parola, ciccione che mangia nell’ultima fila, è inutile che ti guardi intorno stupito, ho visto che alzavi un sopracciglio mentre rovistavi nelle patatine, e non dire che cercavi la sorpresina! — era la materia in cui più eccellevo.
Anni e anni d’esperienza mi avevano reso perfetto, e se a questo si aggiunge che sono sempre stato piuttosto atarassico, diventa chiaro che razza di macchina diabolica anti-studio fossi diventato. Il tempo passava e gli esami si avvicinavano. E io con ‘sta faccia imperturbabile. Mancava una settimana e la faccia non cambiava. Mancavano quattro giorni e la faccia non cambiava. Non aprivo libro. Mancavano tre giorni e finalmente la forza di volontà faceva breccia nella fortezza della pigrizia e studiavo. Leggevo.
20 pagine.
Domani andrà meglio, mi dicevo, e la faccia non cambiava. Mancavano due giorni e, avendo studiato il giorno prima, questo lo facevo passare senza sentirmi in colpa e senza fare niente. La faccia non cambiava. Il giorno prima dell’esame, da bravo studente diligente andavo in biblioteca e ci rimanevo finché non collassavo per il torcicollo e la stanchezza. Soddisfatto ed orgoglioso andavo a letto, sicuro di me e la faccia imperturbabile si trasformava in un sorriso. Il giorno seguente passavo l’esame e non capivo come la gente potesse studiare mesi e mesi e andare in panico per certe cose, quindi tornavo a casa.
E la faccia non cambiava.