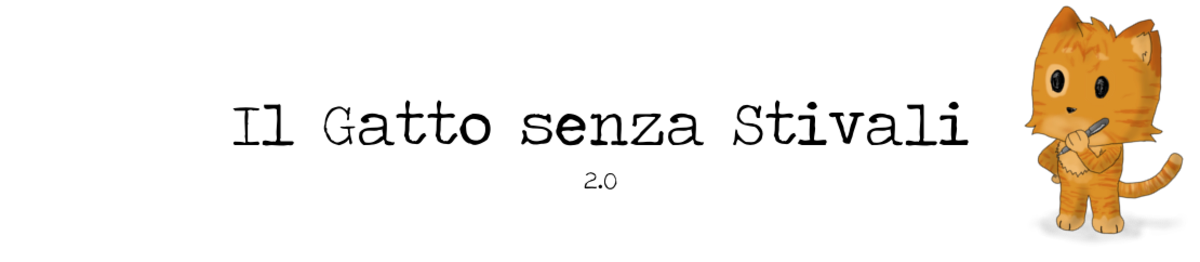Cara lettrice sconosciuta,
in pure stile gattiano (cioè io, in puro stile mio. Senza un aggettivo in -ano la frase non filava altrettanto bene. Ed ecco che inizio già con le tangenti, nemmeno ho iniziato il post, mannaggia)…
Dicevo: in pure stile gattiano, trasformo leggermente frasi che mi piacciono e/o considero di dominio pubblico per poi paralizzarmi e pensare: ma sarà vero?
No, va be’, ricominciamo di nuovo.
“Di che parlo quando parlo di scrivere” è un prestito di un bellissimo titolo di un altrettanto bellissimo libro di Murakami, che in Italia, perché evidentemente siamo stronzi, abbiamo tradotto male come “L’arte di correre”. In puro stile gattiano l’ho trasformato in scrivere, e visti i miei precedenti non potevo certo chiamarlo “L’arte di scrivere”, quindi ho optato per la traduzione letterale.
Nel libro Murakami racconta del suo rapporto con la corsa. Le maratone, le lunghe ore al freddo, al caldo, a mettere un piede davanti all’altro a ritmo costante. Racconta di come finisca a conoscere, pur senza mai scambiarsi una parola, i corridori più assidui di Tokyo. Di cosa lo spinge a uscire ogni giorno, di come per qualche anno ha smesso, come un qualsiasi fumatore incallito, per poi ricascarci e non uscirne più. Lo fa con quel suo stile onirico, che ti ingarbuglia la testa e fa suonare poetica qualsiasi cosa.
E ti fa venire voglia di metterti le scarpe e uscire a correre. Di provare quelle cose di cui scrive e che anche tu vorresti provare.
E magari un paio di volte mi ci ha pure convito, ma non di più. Perché io quelle cose non le provo. Sarò anche un pazzo scatenato, ma no, a me correre senza meta non rilassa, non innamora, e non aiuta a pensare.
E di aiuto per pensare, sinceramente, non ne avrei nemmeno bisogno. Il contrario, semmai.
Il problema è riuscire a pensare a una cosa sola, e poi farla. E rifarla. E rifarla. E rifarla fino a quando non si ha finito. La maggior parte delle volte, alla quinta mi sono stufato e sto già pensando ad altro.
Quando parlo di scrivere, quindi, quando penso e affermo “va là, che voglia di scrivere un libro su questo tema!”, in realtà la mia mente di sdoppia, o forse striplica (abbi pazienza, non ho ancora deciso, vado a braccio). Una parte si gasa, vedendosi già a opera conclusa: tronfia, ebbra e vincente; una seconda parte inizia già a predisporre il necessario: avremo bisogno di acqua e viveri per almeno sei anni (sono lento), di eseguire le dovute ricerche in tema di X, dovrà per forza accadere almeno Y e Z, eccetera, eccetera; una terza parte si preoccupa, conscia che le probabilità di successo sono simili a quelle di vincere la lotteria senza giocare (che poi credo che siano le stesse di vincerla giocando); e una quarta parte (ecco, vedi, dovevo dire squadruplica) si fa prendere dall’ilarità, un po’ perché in effetti fa ridere, e un po’ perché è assai sempliciotta, questa mia parte.
Quando dico che scriverò qualcosa, è come se mi preparassi alla battaglia campale più terrificante che tu possa immaginare, e forse anche peggio, perché la mia immaginazione è probabilmente più infida.
E allora perché, perché diavolo continuo a dirlo, continuo a pensarlo, continuo a desiderarlo? Perché mi intrappolo cosi? Non potrei semplicemente dire “e mo basta veramente, però”?
No. Non lo faccio. Continuo a illudermi e a vivere coi sensi di colpa. E questi post sono una gradevole palestra futurista, dove i sensi di colpa per non scrivere si placano un poco.
Però, oh, io giuro che mo scrivo. Mo scrivo davvero: qui lo dico e qui non lo nego.
Magari per i pirati dovrai aspettare un altro po’, perché sono inciampato già ai primi capitoli, ma ho di recente riletto il poco che avevo scritto per Charlie, e a distanza di quasi tre anni, ha tenuto botta: mi piace, fa ridere, non necessita di troppa ricerca, e boh, io allora lo scrivo, ‘sto libro con gli zombi.